IL PASSO
ULTIMA ORA
ELOGIO ALLA REGINA DEL BOSCO
IN UN PANORAMA ORNITOLOGICO INVERNALE INSODDISFACENTE
Assenti i grandi turdidi mentre si registra l’ottima presenza della Beccaccia
Deludono Lucherini e Peppole
(25/03/2025)
Il programma Copernicus ha decretato il 2024 come anno più caldo a livello globale a causa delle alte temperature medie riscontrate facendogli guadagnare così un nuovo record. Dopo un mese di novembre con temperature leggermente al di sopra della media, dicembre è stato più fresco e nevoso al centro e sud Italia ma questa situazione, insieme alle varie oscillazioni avvenute in varie zone del Belpaese, non ha contribuito a mitigare la media annuale registrata. Nelle stesse condizioni si apre il 2025, con un gennaio che ha ricalcato la tendenza a un riscaldamento globale, fenomeno che sta rendendo l’Italia particolarmente vulnerabile sotto questo aspetto. E così un inverno ancora poco inverno ha condizionato la presenza (anzi, l’assenza) degli uccelli sui nostri territori. Gli amici alati si sono visti ma con contingenti poco numerosi. Addirittura, alcune specie ci hanno snobbato, come la Cesena che ha dimostrato una scarsa presenza sul territorio arrivando ad esser quasi nulla in alcune regioni del centro Italia. I Tordi sasselli sono stati più numerosi nella prima parte dell’inverno lasciandosi poi desiderare per tutta la stagione. Delusione per il Merlo che ha replicato la sua scarsa presenza autunnale. Sembra che le popolazioni abbiano subito un calo numerico tanto che anche i cittadini meno ferrati in materia hanno notato la scarsa presenza tra i giardini e i parchi urbani. Sono poche le specie che hanno testimoniato un buon numero di presenze. Tra queste, in particolar modo, la Beccaccia vista dalle Alpi agli Appennini in ottime quantità e distribuzione territoriale, tanto che secondo i rilevatori era più di quarant’anni che non se ne vedevano così tante. A lei si aggiunge la costante presenza del Fringuello, dello Storno, del Pettirosso e del Colombaccio, che da diversi anni continuano a presentarsi numerosi. Quest’inverno però hanno deluso i Lucherini e le Peppole, queste ultime presenti in modo massiccio nell’inverno 23/24. Tra i fringillidi qualche Frosone in più si è fatto osservare confermando la sua presenza, dopo diversi anni di scarsità, notata in autunno. In campagne coltivate buona la presenza dell’Allodola e del Fanello ma scarsa quella della Pispola con contingenti poco numerosi. Pochi, come sono da alcuni anni, anche gli Spioncelli. Parlando degli acquatici, sono state registrate sempre in buon numero le anatre di superficie come i Germani reali e le Alzavole associati ai tuffatori Moriglioni, mentre sono stati osservati in ottimo numero le Folaghe, le
Gallinelle d’acqua, le Avocette, i Piovanelli pancianera e le Oche in generale. Degno di attenzione è l’aumento di Ibis sacro che da diverso tempo frequenta i territori a lui congeniali destando, in qualità di specie aliena, qualche preoccupazione circa la sua continua espansione territoriale e il suo impatto con l’avifauna autoctona. Interessanti anche le presenze del Beccaccino, per quanto localizzate nei territori adatti come le aree umide, le stoppie di riso o le classiche marcite che però, da tempo ormai, sono in drastica diminuzione a causa dell’agricoltura intensiva che non ne avverte più la necessità, nonché per un consumo di suolo agricolo troppo elevato e senza rispetto del mondo naturale. Quest’ultima situazione infatti sta causando la perdita d’habitat per molte specie animali con la conseguente rarefazione delle specie che una volta in certi luoghi, ora ridotti o scomparsi, erano abbondanti. Inoltre, a questa causa si aggiunge l’innalzamento della salinità delle zone lacustri e l’influenza aviaria ad alta patogenicità che ha già causato la perdita di molti soggetti tra gli uccelli acquatici selvatici. Fenomeni, questi, che inducono ogni fruitore della natura a tener conto di qualsiasi cambiamento che si riscontri nel proprio territorio sperando che eventuali segnalazioni di degrado o peggioramento possano indurre gli organismi preposti a intervenire almeno per mitigare la situazione. Si arriva così a febbraio, mese che annuncia i primi movimenti erratici di preparazione alla migrazione primaverile e il prossimo ritorno ai lidi di nidificazione. Durante la stesura di queste note, il meteo sta subendo l’arrivo di perturbazioni con pioggia, neve e temperature più basse incoraggiando le specie alate a raggrupparsi dove c’è ancora cibo. Avvengono cosi le prime segnalazioni di gruppi di grandi turdidi e fringillidi che si mischiano e si rincorrono manifestando una certa frenesia tipica delle specie migratrici. E mentre in cielo compaiono le prime Gru che si dirigono verso nord, si aspettano i prossimi mesi con l’ansia e con la speranza di vedere cieli più trafficati e aree naturali più frequentate con voli e canti che annunciano l’arrivo della bella stagione. (Walter Sassi)
Gallinelle d’acqua, le Avocette, i Piovanelli pancianera e le Oche in generale. Degno di attenzione è l’aumento di Ibis sacro che da diverso tempo frequenta i territori a lui congeniali destando, in qualità di specie aliena, qualche preoccupazione circa la sua continua espansione territoriale e il suo impatto con l’avifauna autoctona. Interessanti anche le presenze del Beccaccino, per quanto localizzate nei territori adatti come le aree umide, le stoppie di riso o le classiche marcite che però, da tempo ormai, sono in drastica diminuzione a causa dell’agricoltura intensiva che non ne avverte più la necessità, nonché per un consumo di suolo agricolo troppo elevato e senza rispetto del mondo naturale. Quest’ultima situazione infatti sta causando la perdita d’habitat per molte specie animali con la conseguente rarefazione delle specie che una volta in certi luoghi, ora ridotti o scomparsi, erano abbondanti. Inoltre, a questa causa si aggiunge l’innalzamento della salinità delle zone lacustri e l’influenza aviaria ad alta patogenicità che ha già causato la perdita di molti soggetti tra gli uccelli acquatici selvatici. Fenomeni, questi, che inducono ogni fruitore della natura a tener conto di qualsiasi cambiamento che si riscontri nel proprio territorio sperando che eventuali segnalazioni di degrado o peggioramento possano indurre gli organismi preposti a intervenire almeno per mitigare la situazione. Si arriva così a febbraio, mese che annuncia i primi movimenti erratici di preparazione alla migrazione primaverile e il prossimo ritorno ai lidi di nidificazione. Durante la stesura di queste note, il meteo sta subendo l’arrivo di perturbazioni con pioggia, neve e temperature più basse incoraggiando le specie alate a raggrupparsi dove c’è ancora cibo. Avvengono cosi le prime segnalazioni di gruppi di grandi turdidi e fringillidi che si mischiano e si rincorrono manifestando una certa frenesia tipica delle specie migratrici. E mentre in cielo compaiono le prime Gru che si dirigono verso nord, si aspettano i prossimi mesi con l’ansia e con la speranza di vedere cieli più trafficati e aree naturali più frequentate con voli e canti che annunciano l’arrivo della bella stagione. (Walter Sassi)
IL RECORD DEL FRULLINO
(24/03/2025)
Parente stretto del Beccaccino, del Croccolone e della Beccaccia, il Frullino (Lymnocriptes minimus) è uno scolopacide di piccole dimensioni con un volo rapido capace di percorrere lunghe distanze in poco tempo. Ne è il classico esempio l’individuo marcato con un Gps da alcuni ricercatori inglesi nel South Staffordshire dove è attiva da tempo un’associazione ornitologica che opera per la sua salvaguardia e studia i suoi spostamenti migratori. Il Frullino è un piccolo uccello lungo circa 20 cm. che frequenta i terreni paludosi e gli acquitrini. Lo stupore degli studiosi è scoppiato quando, seguendo l’esemplare da remoto, hanno tracciato il suo incredibile percorso lungo più di mille chilometri. In primavera dopo aver lasciato l’Inghilterra, il Frullino ha superato il Mare del Nord per poi sorvolare la Germania arrivando in Polonia. Ma la cosa più sorprendente è stata la durata del tragitto, coperto in soli tre giorni. Inoltre, il suo viaggio non è finito in Polonia poiché, dopo essersi riposato, è ripartito verso est dirigendosi in Lettonia. Da questo punto la batteria del Gps si è scaricata smettendo di rilevare la posizione geografica. L’idea è che sia arrivato fino alle steppe della Russia per riprodursi d’estate. Un viaggio da record che non può altro che lasciare sbalorditi coloro che studiano il fenomeno della migrazione. (W.S.)
LE CINCE, PASSERIFORMI INSAZIABILI
(24/03/2025)
La denominazione cincia è una derivazione onomatopeica del termine "ciancia" o "ciarla" ossia che chiacchera. Questa denominazione è stata attribuita a quei piccoli passeriformi che durante i loro spostamenti continuano a tenersi in contatto coi loro richiami. Ne sono di esempio appunto le Cince, famiglia Paridae, che, mentre cercano nutrimento tra le fronde degli alberi muovendosi in gruppo, continuano a tenersi in contatto con un cinguettio insistente. Sembra che tale richiamo serva per comunicare ai membri del gruppo il ritrovamento di una preda oppure possa essere una sollecitazione alla ricerca di prede in quel determinato luogo ricco di nutrimento. Le cince sono uccelli insettivori e hanno, al pari delle altre specie del loro genere, bisogno di mangiare in continuazione in quanto la loro dieta non consente un’abbuffata semplice perché l'inseguimento e la cattura della preda è assai più difficoltosa e meno proficua che il nutrirsi di semi e frutti dalle piante, come fanno le specie granivore. Ne consegue che per sfamarsi a dovere la vita frenetica delle cince è impegnata all’80% nella ricerca del cibo. Specie abbastanza confidenti, si lasciano avvicinare facilmente tanto che non è difficile scorgerle mentre, alla ricerca di cibo, si lasciano dondolare a testa in giù, oppure fanno mille acrobazie, emettendo il loro caratteristico richiamo. Molte di queste emissioni intermittenti sono accompagnate da leggeri movimenti di ali o tremolii della coda. Un comportamento simile lo svolgono i giovani quando richiedono l'imbeccata ai genitori. Alcuni ornitologi pensano che questa intermittente vocalizzazione degli adulti sia un residuo stilizzato del richiamo infantile e che quindi conservi il significato di "plauso alimentare". Vi è poi da sottolineare che alcuni studiosi hanno scoperto che la Cincia mora (Parus ater) dal peso di circa tredici grammi, per mantenersi attiva deve nutrirsi almeno di trecento coccinelle oppure, alla pari, di un notevole numero di uova o larve di insetti più piccoli. Non c'è che dire: stando a questi dati, le cince sono un'ottima lotta biologica alla proliferazione degli insetti che minacciano l'equilibrio ambientale. Per questo in alcune colture agricole sono stati installati nidi artificiali atti ad incrementare le popolazioni di questi graziosi uccelletti. Non solo, ma si è potuto verificare che durante le massicce infestazioni di insetti tipo Limantridae in un determinato territorio il numero di esemplari di questa famiglia si moltiplica sino a otto volte rispetto al numero di esemplari presenti nei territori esenti da questo fenomeno. Ne è esempio un episodio accaduto novant'anni fa quando in alcune foreste dell'Ucraina ci fu un'invasione di Porthesia similis e le Cinciallegre (Parus major) che giunsero nella zona distrussero il 74% dei nidi di bruchi di questo insetto. (W.S.)
UNA MIGRAZIONE AUTUNNALE AVARA:
2024, UN AUTUNNO “STORTO”
(12/11/2024)
C’eravamo lasciati in giugno con le note sul passo primaverile deludente, caratterizzato da un meteo poco clemente e con la speranza di una ripresa del passo nella stagione estivo-autunnale ma, se dobbiamo dirla tutta, ci sarebbe da commentare di più sulle vicende causate dal maltempo che sul passaggio dei nostri amici alati nei nostri territori. É doveroso sottolineare che parlare della migrazione è sempre complicato poiché il suo svolgimento è vario a seconda del territorio e delle relative abitudini che gli amici alati possiedono causando così diverse impressioni. Cercare un punto d’incontro su ciò che succede diventa quindi impegnativo. Sebbene tutte le specie siano state presenti, vi è da sottolineare la loro scarsa presenza numerica che è stata più o meno marcata e sottolineando come la stagione appena trascorsa sia stata avara. Mentre il mese di agosto è stato uno dei più caldi dal 1800 ad oggi con fenomeni temporaleschi molto intensi, la migrazione è iniziata con la partenza dei Rondoni e dei Balestrucci dai quartieri di nidificazione urbani confermando però anche in questo anno, come già da tempo si nota, una loro importante diminuzione. Tra le specie transahariane si è notata una buona presenza della Balia nera che già nella prima decade di agosto ha fatto la sua comparsa unitamente a Prispolone e Stiaccino anch’essi in buon numero. Scarsi i Culbianchi, i Luì grossi e i Luì verdi nonché i Beccafichi. Nulla da segnalare per quanto riguarda la Quaglia e la Tortora selvatica che, secondo i rilevatori, hanno mantenuto nei territori a loro congeniali una discreta presenza. Sempre ad agosto, come da calendario, si sono notati i primi movimenti dei limicoli come i vari Piro piro, Piovanelli, Beccaccini e anatidi. Settembre è apparso in controtendenza rispetto a quelli trascorsi e, a causa delle correnti d’aria fresca provenienti dal Nord Europa, si manifesta con temperature miti e con frequenti piogge che innescano eventi alluvionali come successo in Emilia-Romagna. Il mese si apre così al Nord con la speranza di osservare i primi Tordi bottacci che appaiono in modo scarso dalla seconda decade del mese senza però soddisfare gli appassionati dei grandi turdidi. Infatti, unitamente al Merlo, il Tordo bottaccio si farà desiderare per tutto il periodo della migrazione regalando, si fa per dire, solo una o due giornate che saranno considerate probabilmente le cosiddette prime “furie”. In questo mese alle specie transahariane già citate, che continuano a manifestare una buona presenza, si aggiunge l’ottima presenza del Colombaccio, dello Storno, del Pettirosso e quella, sebbene non eclatante, del Pigliamosche e del Codirosso. Nulla da segnalare per quanto riguarda i Fringillidi che però, con ottobre, fanno la loro ottima comparsa con il Fringuello accompagnato dal Frosone, quest’ultimo tornato presente in piccoli gruppetti in diverse zone dopo anni di assenza. Unitamente poi, come siamo abituati a vedere, si aggregano Fanello, Lucherino e Peppola. Ottobre è stato caratterizzato da molte e intense piogge, definendo l’autunno di quest’anno come uno dei più piovosi degli ultimi decenni. In molte regioni italiane come la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, le Marche e ancora l’Emilia-Romagna, per i fortissimi temporali e i nubifragi, si sono registrati altri eventi alluvionali. Occorre comunque dire che sul versante orientale e adriatico è andata decisamente meglio rispetto al versante occidentale tirrenico della Penisola, grazie a condizioni meteo più favorevoli alla migrazione ottobrina. Tornando all’analisi del passo nelle campagne, dalla prima decade di ottobre compaiono in buon numero Pispole e Allodole mentre, ancora una volta, lo Spioncello si osserva in modo irregolare e localizzato. Anche per il Fanello i numeri sono un po’ sottotono. Come già detto prima, il Merlo e il Tordo bottaccio non danno ancora soddisfazioni e sebbene localizzati sono osservati in numero ridotto rispetto agli scorsi anni. Alcuni rilevatori segnalano persino una notevole scarsità di numero delle specie nel loro territorio. A parte la “furia”, se così possiamo definirla e sempre sotto la media, della seconda decade del mese, questa situazione non cambierà nel corso della stagione e solo l’arrivo dei primi Tordi sasselli nell’ultima decade del mese placherà un pochino le delusioni degli appassionati di questi grandi turdidi. Il mese segna l’arrivo a quote più basse della Passera scopaiola, del Luì piccolo e ancora l’ottima presenza del Colombaccio, dello Storno e del Pettirosso. In montagna e collina vengono osservate diverse Beccacce (le prime al piano sono avvistate nel corso della terza decade del mese), mentre nelle valli non ci sono elementi di rilievo per quanto riguarda le specie acquatiche. E mentre il periodo principale della migrazione autunnale volge al termine, osservando i cieli che vedono le Gru transitare verso lidi più caldi, la speranza si aggrappa all’osservazione di quelle specie che dovrebbero presentarsi a novembre per poi trascorrere l’inverno a quote un po' più basse. Ci riferiamo alle segnalazioni delle mitiche Cesene dalla media collina alla pianura. Staremo a vedere l’evoluzione dei movimenti migratori la cui conoscenza è molto rilevante per la comprensione dell’eco-biologia degli uccelli poiché possono dare risposte alle esigenze di carattere applicativo e gestionale. Attraverso la conoscenza dei tempi e delle rotte di spostamento si possono definire programmi di tutela gestendoli in modo più adatto ai siti e nei periodi più appropriati. Molte informazioni oggi disponibili sulla migrazione degli uccelli hanno avuto nell’osservazione sul campo uno strumento efficace. (W. Sassi)
LE ROTTE MIGRATORIE CAMBIANO
(11/11/2024)
Le modificazioni ambientali, registrate negli ultimi anni, hanno condizionato la vita sulla Terra. Spesso si è sentito parlare di effetto serra dovuto all’aumento di anidride carbonica nell’aria, gas prodotto dalle attività umane, della desertificazione che causa l’impoverimento della copertura vegetale delle aree equatoriali con distruzione dei suoli che, non più fertili, non possono dar luogo a ecosistemi, del sovrappopolamento e di antropizzazione, con conseguente deprivazione degli ambienti naturali a favore delle costruzioni umane. Il legame che esiste tra questi fenomeni e l’avifauna ha influito sulle abitudini plurimillenarie degli uccelli migratori. A tal proposito le ultime tendenze dimostrano come diverse specie di uccelli siano costrette a cambiare la direzione di migrazione per diverse cause: non trovano più area di sosta, gli areali di nidificazione o di svernamento non offrono più condizioni ambientali favorevoli per la loro sopravvivenza, i cambiamenti ambientali rendono ospitali aree che prima erano meno miti, ma che ora, più calde, possono essere occupate. L’agricoltura intensiva si sostituisce agli ambienti naturali e le poche stalle sopravvissute non sono sufficienti per la costruzione di nidi, vedi il caso delle rondini. Per monitorare questi cambiamenti ambientali, conserva importanza l’attività d’inanellamento che, grazie alle ricatture di uccelli precedentemente inanellati, offre l’opportunità di studiare gli areali di provenienza, individuare le aree di sosta durante il volo migratorio e censire quali siano i luoghi di svernamento delle specie ornitiche. In questo modo è possibile registrare quali siano i cambiamenti nelle direzioni di migrazione e ricercarne le cause. Buone notizie riguardano il ritorno della cicogna bianca, del nibbio bruno e del falco pellegrino ma altre contrastanti sottolineano come molte altre specie siano in declino. L’aumento globale della temperatura induce diverse specie ad anticipare il periodo di riproduzione o a non intraprendere il viaggio di ritorno. Infatti, se è vero che l’istinto migratorio è determinato genericamente, è necessario rammentare che anche l’esperienza e l’adattamento agiscono favorendo la modificazione del comportamento. I cambiamenti ambientali dovuti all’interazione con l’uomo sono, però, spesso repentini e gli uccelli non riescono ad adattarsi correndo rischi di rarefazione: investire nel recupero ambientale e nell’agricoltura estensiva sarebbe certamente di aiuto agli uccelli. (W.S.)
UNA TRISTE PRIMAVERA E UN RIPASSO PARZIALMENTE DELUDENTE
(23/07/2024)
É quello che è successo in quest’ultima stagione del 2024 sul territorio italiano dove la migrazione è stata penalizzata da un tempo meteo negativo per quasi tutto il periodo, caratterizzato da giornate altalenanti tra temperature sotto la norma stagionale e una piovosità a volte quasi estrema. In questo contesto dall’inizio del ripasso primaverile gli uccelli transahariani, una volta giunti sulla terra ferma, hanno trovato condizioni favorevoli al sud ma solo in poche giornate al centro e nord Italia. Si è così assistito a una buona presenza dell’avifauna quasi soltanto al sud. Sebbene tutte le specie caratteristiche del periodo si siano fatte notare vi è però da sottolineare l’insufficiente numero dei loro individui, un elemento questo che si rileva da tempo. Tanto che ad oggi alcune coppie riproduttrici in determinate zone, dove solitamente erano presenti, quest’anno non si sono presentate. Non è facile fare una sintesi di questo problema, ma teorie avanzate da più parti concordano che la causa possa essere un calo di biodiversità nei territori di svernamento a causa di un consumo sconsiderato di suolo che, tra l’altro, si sta verificando anche in troppe aree del nostro amato paese. A questo si somma il cambiamento climatico, problema sottolineato da diversi anni e aggravato dalle attività umane, che sta cambiando le abitudini degli uccelli. Ci sono prove evidenti che Il pianeta dal 1970 si stia riscaldando sempre più velocemente. In questo contesto, lo scriviamo spesso, in Italia è comunque tutt’oggi possibile osservare il fenomeno migratorio. In tutto il territorio, oltre a stare col naso all’insù, come scrive qualcuno, nelle aree boschive e dalle rive di laghi, fiumi e specchi d’acqua si può scoprire e osservare gran parte dell’avifauna migratrice che si rifugia per un breve periodo alla ricerca di cibo mentre fa una pausa prima di riprendere il viaggio verso i lidi di riproduzione. Grazie all’agenzia Copernicus, un breve riassunto di ciò che è successo in quest’ultima primavera lo possiamo già elencare partendo da un mese di marzo caratterizzato da ottime precipitazioni che seguono quelle di gennaio e febbraio e da una temperatura media al di sopra di quasi un grado che ha influito sull’umidità dell’aria. Aprile ha manifestato marcate oscillazioni termiche causando il quarto anno consecutivo con freddo intenso in Europa a causa di più discese di masse d’aria di origine artica. Arriviamo così a maggio con temperature sotto la media stagionale, che hanno determinato elevata piovosità e più freddo della norma, soprattutto al nord. Un trend in controtendenza rispetto alle mensilità invernali e primaverili che negli ultimi anni avevano segnato record storici di caldo a livello italiano. É quindi logico pensare come la migrazione dei nostri amici alati venga influenzata notevolmente. Tuttavia, le incognite e le sorprese, si sa, fanno parte del fenomeno migratorio ed è sempre interessante frequentare la natura per osservare quanto ci può offrire anche se a volte non ci è molto gradito. Speriamo in una estate più proficua sotto il profilo meteorologico che possa agevolare la vita degli alati indaffarati nell’allevamento della prole anche se, mentre scriviamo queste note, la bella e calda stagione non è ancora partita e siamo già alla terza decade di giugno! (Walter Sassi)
COME ALLEVARE TORDI COMUNI, MUTATI ED ESOTICI
(23/07/2024)
Siamo alla terza edizione di questo interessante volume e, ovviamente, come ogni edizione che si rispetti anche questa è ricca di nuove informazioni. Il libro nasce dalla passione per l'allevamento amatoriale di specie interessanti sotto il profilo ornitologico grazie alla loro intelligenza, vivacità, canto e bellezza cromatica. Qualità che hanno sempre attratto molti ornitofili. Conoscendo l'autore, coadiuvato da un ottimo allevatore, non mi sorprende vedere quante informazioni si possano ricavare dalla lettura di questo volume. Qui, chi vuole cimentarsi nella detenzione dei grandi turdidi può apprendere tante nozioni che lo possono aiutare a ottenere solo grandi soddisfazioni mettendoci, s'intende, anche il suo impegno nell'allevamento. Un aiuto, senza dubbio molto efficace, che renderà meno difficile cimentarsi nella pratica dell'allevamento già di per sé complessa. Coloro che frequentano l'ambiente, sanno con certezza quanto sacrificio ci sia dietro ai risultati che ogni allevatore ottiene ogni anno da una coppia in riproduzione. A volte l'insuccesso è dietro l'angolo e basta poco per demoralizzarsi e abbandonare tale pratica. I consigli dei veterani esperti possono giovare ai novizi ma anche a chi da anni alleva con determinazione per ottenere soggetti di interessante valore morfologico e vocale. Questo libro è come uno di questi allevatori esperti che indicano il modo migliore per arrivare al buon risultato. Tanti capitoli accompagnati da belle foto a colori arricchiscono il testo, che parte dalla conoscenza della famiglia ornitica dei turdidi e delle grandi specie qui trattate e la sua distribuzione nel mondo, toccando la tematica morfologica delle mutazioni e l'ibridazione. Nel testo sono presenti capitoli approfonditi sugli ambienti adatti dove allevare, sull'alimentazione e sulla sua integrazione con gli elementi animali e minerali naturali adatti, sulla preparazione alla stagione delle cove e sull'allevamento della prole sino al suo svezzamento. Infine, un capitolo è dedicato alla salute dei nostri beniamini e alle loro cure in caso di malattie. Chiude il tutto una lunga bibliografia di articoli e libri dedicati ai turdidi consultata dall'autore e da consultare da parte di coloro che ne sono interessati. Un volume consigliato a chi si dedica anima e cervello a questo mondo affascinante e alle sue creature che lo animano. Chi fosse interessato al volume Come allevare tordi comuni, mutati ed esotici di Luca Gorreri con la collaborazione di Daniele Bedogni (pagg. 224 con fotografie a colori) può richiederlo alla Pacini Editore attraverso il sito web www.pacinieditore.it oppure scrivendo una mail a info@pacinieditore.it 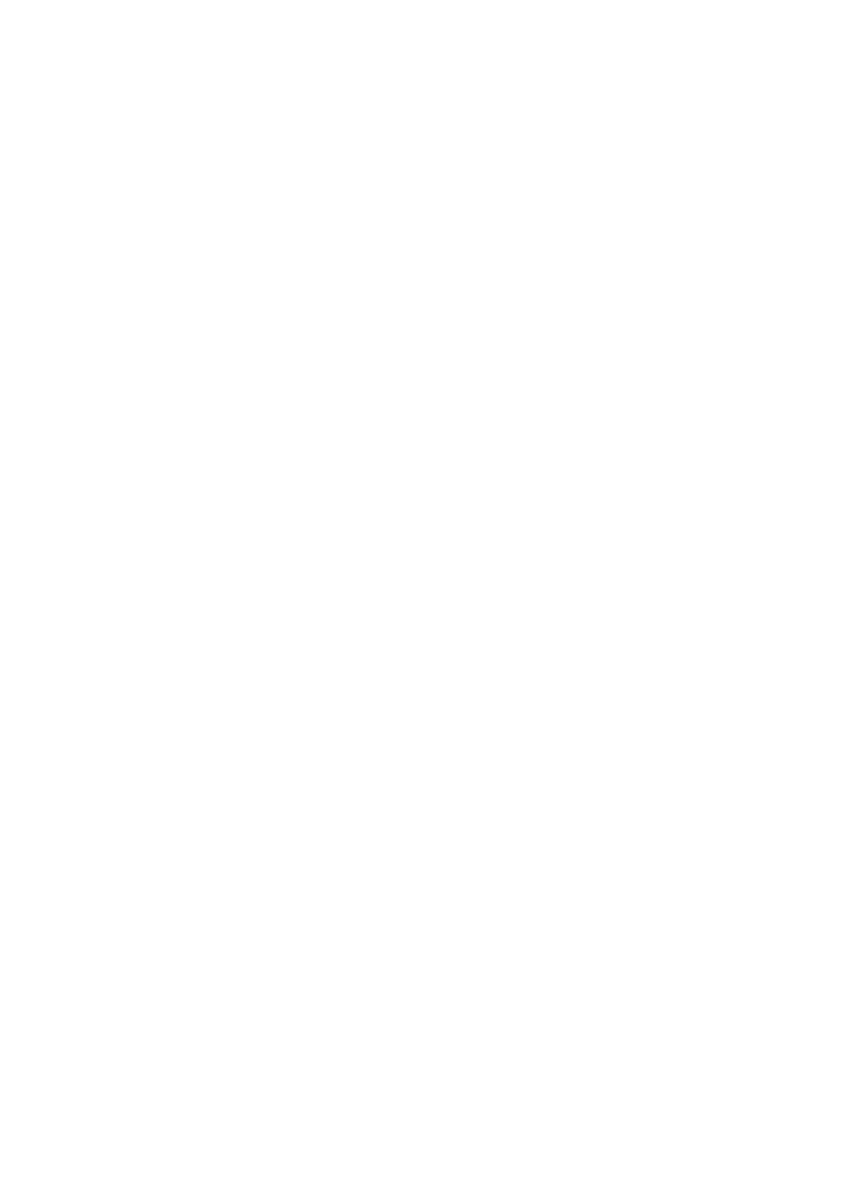

ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI NEL PARCO REGIONALE
GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE
(02/07/2024)
É stato pubblicato un nuovo atlante ornitologico, risultato di un’indagine che dispone di una banca dati importante sulle specie nidificanti nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. É il secondo atlante ornitologico della Basilicata, ma ancora molto vi è da fare per il territorio Lucano in quanto sono ancora pochi i lavori di sintesi che analizzano il popolamento dell’avifauna, mancando di fatto un vero e proprio atlante regionale. Il presente volume è ricco di informazioni fornite in modo accurato accompagnate da una variegata e professionale raccolta fotografica. Tali informazioni vengono presentate sotto forma di carte tematiche corredate da un testo descrittivo per ogni singola specie. Durante la ricerca svolta nel 2020, sono state censite ben 103 specie. Attraverso le mappe di distribuzione e i dati assunti, viene evidenziato come il territorio indagato sia importante sotto il profilo naturalistico e ornitologico. Anche questo atlante, come tutti quelli a oggi realizzati sul territorio nazionale, è uno strumento essenziale per comprendere lo status di alcune specie italiane, tassello di fondamentale importanza per una corretta gestione ambientale e la salvaguardia della biodiversità. Per richiedere il volume Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane (E. Fulco, C. Liuzzi, F. Mastropasqua, E. Mallia, M. Delorenzo, Pag. 254, 230 foto a colori) contattare l’Ente Parco: info@parcogallipolicognato.it - www.parcogallipolicognato.it (W. S.)
https://www.anuu.org/public/ckeditor/data/COPERTINA-ORNITOLOGIA.png
https://www.anuu.org/public/ckeditor/data/COPERTINA-ORNITOLOGIA.png
TUTTI A NASO ALL’INSU’:
LA MIGRAZIONE PRENUZIALE
(05/03/2024)
La migrazione prenuziale 2024 dell’avifauna è in pieno svolgimento. A noi cacciatori piace chiamarla “ripasso”, termine gergale tradizionale che però, occorre precisarlo, si riferisce solo alla parte della migrazione visibile a noi umani. È infatti noto come molte specie, i Turdidi ad esempio, migrino particolarmente nelle ore notturne, oppure altre transitino ad altezze tali da non essere avvistabili a occhio nudo, come fanno molti Anatidi. Pertanto, le quote di migratori che osserviamo di primo mattino, nelle ore diurne e prima del crepuscolo, a tiro del nostro sguardo, sono quelle che definiamo di “ripasso” (e passo nell’autunno), non esaustive dell’intero fenomeno migratorio. In questo periodo, alcune specie, sia per le grandi dimensioni, che per la “rumorosità” e proprio perché ci sorvolano nelle ore di luce, sono particolarmente appariscenti, vedasi ad esempio la Gru (Grus grus), che ormai da alcuni anni è tornata in forze a solcare i nostri cieli nei mesi autunnali e in quelli primaverili. Sui social, i filmati e le fotografie del ripasso delle Gru si sprecano. Si tratterebbe, a ben guardare, di una forma di citizen science, ovvero di quella forma più recente di osservazioni della fauna selvatica che si avvale della collaborazione della gente comune, ovvero di persone che, dotate di un minimo di conoscenze di base – in questo caso, la capacità di discernere tra una specie di uccelli e l’altra – e trovandosi sul territorio, raccolgono appunto video e immagini, che poi diffondono e che possono contribuire alle indagini e ricerche sulla fauna selvatica svolte dagli addetti ai lavori. Si tratta di una fonte potenzialmente rilevante di osservazioni che, in qualche modo, supplisce al numero e alla dislocazione dei ricercatori, inevitabilmente molto più ridotti. Le Gru sono senza dubbio bellissime, di elevato valore simbolico ed evocativo: però, a pensarci bene, non sono certo le sole a compiere viaggi epici. Tutti i piccoli Passeriformi migratori, ad esempio, ne compiono di altrettanto importanti, solo che sono molto più piccoli, volano a bassa o bassissima quota e, magari, lo fanno di notte. Il pettirosso o lo scricciolo e tanti altri, ci rivelano che stanno passando perché ci appaiono oggi nei cespugli dove non c’erano ieri. Una bella sorpresa e un moto di stupore ogni qualvolta pensiamo a come riescano pochi grammi di piume a percorrere certe distanze e a superare certi ostacoli. È poi indubitabile che l’ammirare nel cielo i grandiosi branchi di colombacci piuttosto che le V disegnate dalle gru, certamente regali emozioni più intense e significative. Insomma, gli uccelli ripassano e stanno ripassando in relativa abbondanza. Restiamo in attesa delle prime segnalazioni di marzaiole a mare – che nella primavera 2023 furono molto frequenti e rilevanti soprattutto sul lato tirrenico della Penisola, con una messe di video amatoriali in circolazione – e intanto godiamoci il meraviglioso spettacolo, a naso, cellulari e videocamere all’insù. (Palumbus)
IL PASSERO SOLITARIO
(22/01/2024)
É una simpatica monografia che racconta delle gesta del “merlo blu”, il delizioso passeriforme celebrato da Giacomo Leopardi e di come, attraverso l’ornitologia, si possa parlare del mondo, dell’amore, della bellezza, della vita. Nei capitoli sono presenti esperienze vissute dall’autore in contatto con il bellissimo turdide dove vengono analizzate, ma soprattutto raccontate le sue abitudini di vita. Durante la lettura emerge quella sensazione d’immersione nel mondo naturalistico in cui la presenza del passeriforme si armonizza con l’ambiente circostante e i suoi abitanti, amici conviventi del sito frequentato ma anche soggetti pericolosi per l’incolumità della sua vita. Se facile è la sua individuazione mentre canta da ruderi in posizioni elevate per dimostrare la sua forza unita all’armoniosità canora, altrettanto difficile è la scoperta delle sue abitudini più nascoste che solo un ornitologo attento ed appassionato riesce a fare. In questo piccolo libro troviamo una grande e affascinate scoperta raccontata; quella della vita del “merlo blu” composta dal periodo di cova, dalla ricerca delle prede, dall’alimentazione dei piccoli, dai canti, dalla sudditanza del maschio rispetto alla femmina e persino dalle nidificazioni precoci e dai problemi ad esse legati. Il Passero solitario di Angelo Meschini (LIPU Birdlife Italia – pagg. 80 –a.meschini@gmail.com) W.S.
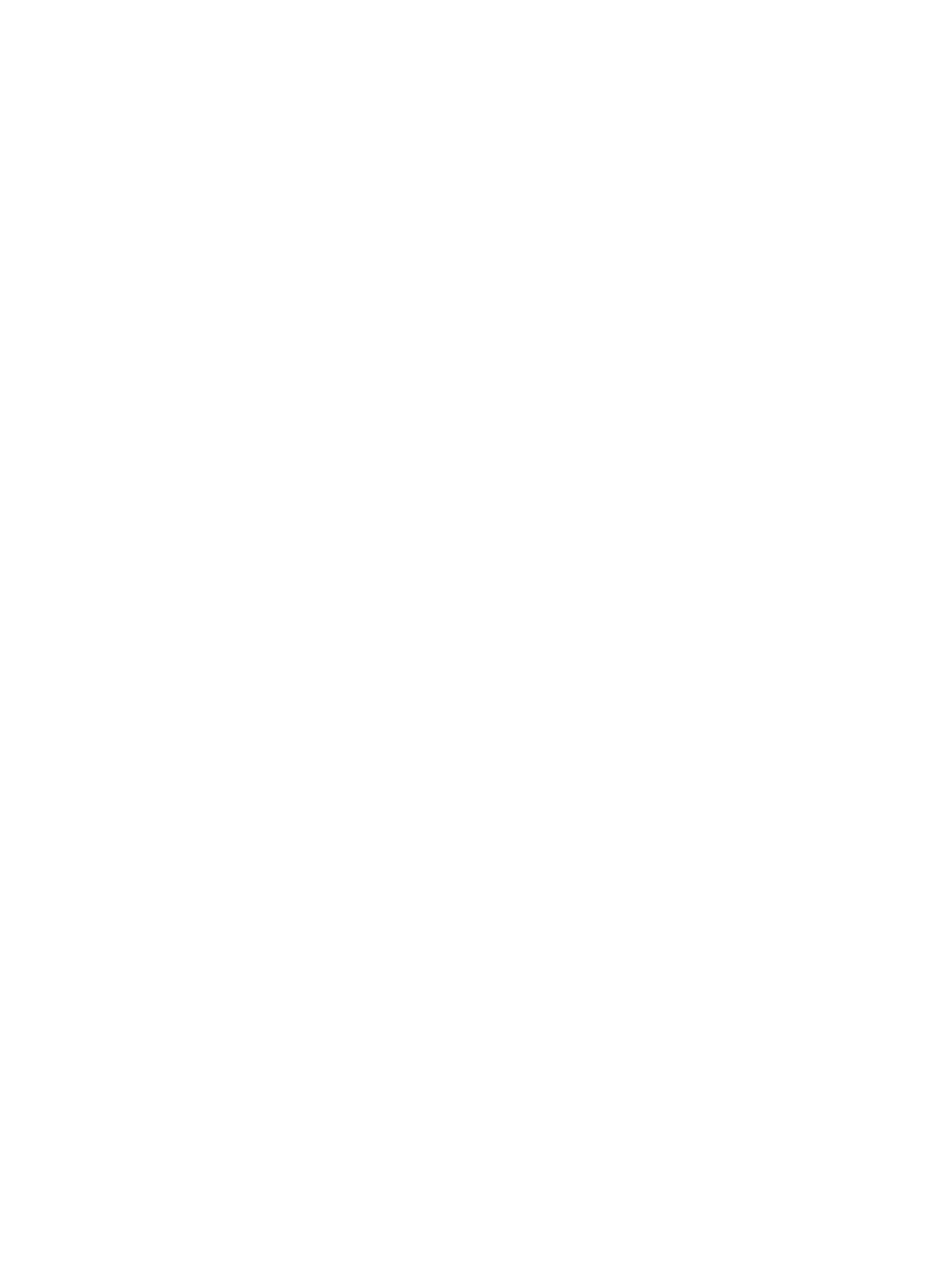

 E' il periodico quadrimestrale ufficiale dell'Associazione, inviato gratuitamente a domicilio a tutti i soci. Esce nei mesi di aprile, agost...
E' il periodico quadrimestrale ufficiale dell'Associazione, inviato gratuitamente a domicilio a tutti i soci. Esce nei mesi di aprile, agost... Un argomento assai spesso dibattuto tra i seguaci di Diana riguarda l’annosa questione della validità del porto d’armi uso caccia (non ...
Un argomento assai spesso dibattuto tra i seguaci di Diana riguarda l’annosa questione della validità del porto d’armi uso caccia (non ...




